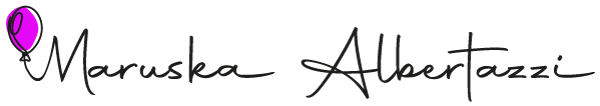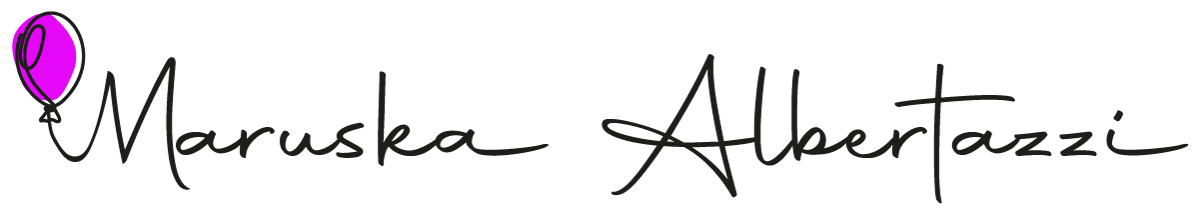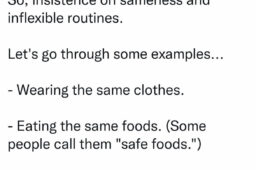L’ortoressia e la paura di morire
Il mio passaggio dall’anoressia all’ortoressia non è stato graduale ma diretto. E’ quello che spesso accade a chi si “cura da sola”, o perché è convinta di poter fare a meno della terapia, oppure perché alla terapia non ha accesso. Molte delle storie di guarigioni in autonomia non sono altro che questo: il salto da un DCA all’altro. Se con l’anoressia non facevo caso a cosa entrava nel mio corpo, a patto che avesse poche calorie, il sacro risveglio dell’ortoressia mi ha portata a selezionare attentamente ogni sostanza che ingerivo, toccavo o addirittura odoravo. Ero così ossessionata dal mantenere il mio corpo sano e incontaminato che persino annusare un profumo commerciale era vietato. Solo oli essenziali, solo creme naturali, solo cibo biologico.
In qualche modo, l’ortoressia è la stampella dei ricchi, il disturbo alimentare più subdolo perché terribilmente classista – quella roba sono in pochi a potersela permettere – e idolatrato dalla cultura della dieta. In effetti, l’ortoressia è il prodotto più raffinato della cultura della dieta, abbracciato persino da governi e specialisti, ed è quello più facile da nascondere.
La mia ortoressia era un’anoressia in disguise. Ho attraversato diverse fasi: quella vegana, quella paleo, quella crudista. Ad un certo punto ho pensato anche di diventare fruttariana, con buona pace della mia resistenza insulinica. Quel pensiero sano di nutrire il corpo con cibo “buono che fa bene” non era più un’idea a cui tendere ma una pratica ossessiva in cui non poteva entrare nemmeno una patatina fritta. O meglio, poteva, ma solo se tagliata a mano, biologica e fritta in olio extravergine di oliva. C’è stato un periodo in cui mangiavo ancora carne ma solo se ero stata io a comprarla. Non al ristorante, non a casa di amici. La carne del supermercato mi terrorizzava. Per molte persone il mio era un comportamento giusto, ero “brava”, e forse a grandi linee avevano anche ragione ma il problema era che se non avevo la possibilità di mangiare il cibo che ritenevo safe, io digiunavo e basta. Il cibo industriale, di qualunque tipo, non poteva in alcun modo entrare nel mio stomaco. Non avevo ben chiaro quale fosse il motivo, non poteva e basta. Anni dopo, con la terapia, ho capito. Era l’ennesimo, estremo tentativo di esorcizzare la morte. Come se, mantenendo il mio corpo nutrito solo con cibo perfettamente “pulito” io potessi controllare le malattie, l’invecchiamento, la morte appunto. Era il mio nuovo rito scaramantico, la mia nuova via di fuga dalla realtà, la mia strada verso l’onnipotenza, il mio delirio di perfezione ed era perfetta, perché non si vedeva. Ero sana, ma solo all’apparenza. Non c’era più una Coca Cola o un aperitivo con le amiche che non fosse una centrifuga, non c’era un bicchiere di vino, non c’erano i pop corn al cinema, non c’era la torta di compleanno (o c’era solo se vegana, crudista e senza zucchero). La mia vita era diventata un inno alla salute ma di vita, là dentro, ce n’era rimasta ben poca.
Allora mangiare bene per stare in salute è un problema? No, non lo è. Il problema è nella rigidità. Il problema è nel terrore che quel cibo considerato malato produce in noi. Il problema è pensare al cibo come a qualcosa che ci possa contaminare, immaginare le nostre cellule che si intossicano, non mollare mai un secondo, scegliere il digiuno anche se si ha fame perché “quella cosa mi farà ammalare”. Certo, ci sono le allergie o le patologie come il diabete o la celiachia ma lo spazio che separa la giusta preoccupazione per la salute dal pensiero rigido e ossessivo sul cibo, per quanto camuffabile, c’è. Il problema è che spesso anche molti professionisti non lo vedono e anzi, spingono i loro e le loro pazienti malati di DCA ad indugiare in quel solco dove il peso è comunque sano ma la mente ancora ingabbiata nella ruota del criceto. E così facendo, in parte comunicano che il problema era solo il peso, in parte suggeriscono che più di così non si possa pretendere. Condannando, di fatto, chi hanno di fronte a fermarsi a metà strada.