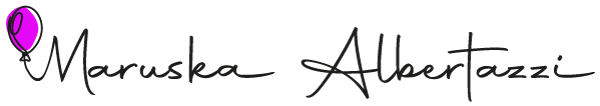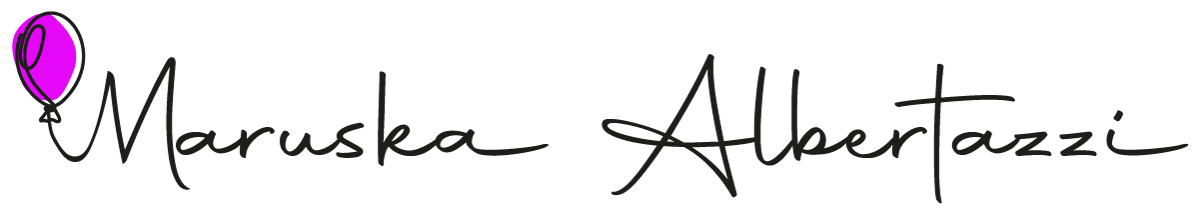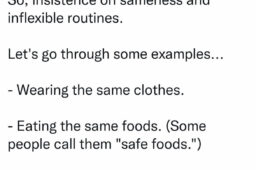Io e la fine della psicanalisi
Mollai l’analisi dopo tre anni, convinta di essere arrivata al miglior risultato possibile con quei mezzi. Su quel lettino c’eravamo concentrati su mio padre, a cui venivano attribuite tutte le mie sventure. Un padre che non c’era mai stato e che era anche morto presto, impedendomi di elaborare il lutto. La mia depressione, secondo l’analista, era il proseguo di quel lutto rimosso che non riuscivo a sbrogliare. Inutile dire che era un Freudiano classico, intriso di quel maschilismo sistemico che ancora oggi fa bella mostra di sé in molti psichiatri e psicoterapeuti: se non è invidia del pene, è mancanza del padre.
C’era una pianta di calle, in quello studio elegante e tetro, posta strategicamente davanti al lettino. La fissavo per tutti e cinquanta i minuti della seduta, nel tentativo di neutralizzare la percezione di assurdità di quella situazione. Io, sdraiata su una chaise longue di velluto color porpora e un uomo di bassa statura e con pochi capelli che non potevo guardare negli occhi ma a cui dovevo raccontare i dettagli più intimi della mia vita. Ogni tanto mi dissociavo, continuavo a parlare e immaginavo che si scaccolasse o che si masturbasse alle mie spalle. A quel punto, senza una ragione apparente, scoppiavo a ridere. Lui scriveva sul suo taccuino, riuscivo a percepire il suono della penna che graffiava il foglio: sono certa la considerasse una prova ulteriore della mia pazzia.
A un certo punto, stanca di appuntarmi i sogni della notte prima e abbastanza convinta dell’assoluta inutilità di quello che stavo facendo, mi alzai dal lettino e non mi ci sdraiai mai più.
Non che stessi bene ma, tolto il sollievo iniziale puramente dovuto all’aver iniziato una relazione terapeutica, all’idea che ci fosse qualcuno che si stava prendendo cura di me, che mi stava finalmente ascoltando e che validava il mio malessere, mi resi conto che quella terapia non mi avrebbe curata.
Così mi rialzai con le mie gambe di legnetti inchiodati e con i miei cassetti aperti alla rinfusa e mi iscrissi a un corso di yoga, che si dimostrò da subito più efficace all’atto pratico.
In realtà, per quanto avessi superato il periodo più brutto relativo alla mia depressione, i sintomi non erano di certo spariti, solo avevo imparato a tenerli a bada con cose “più sane”: lo yoga, appunto, le passeggiate nei prati, gli integratori naturali e un blando antidepressivo, forse l’unica vera certezza del mio percorso fino a quel momento.